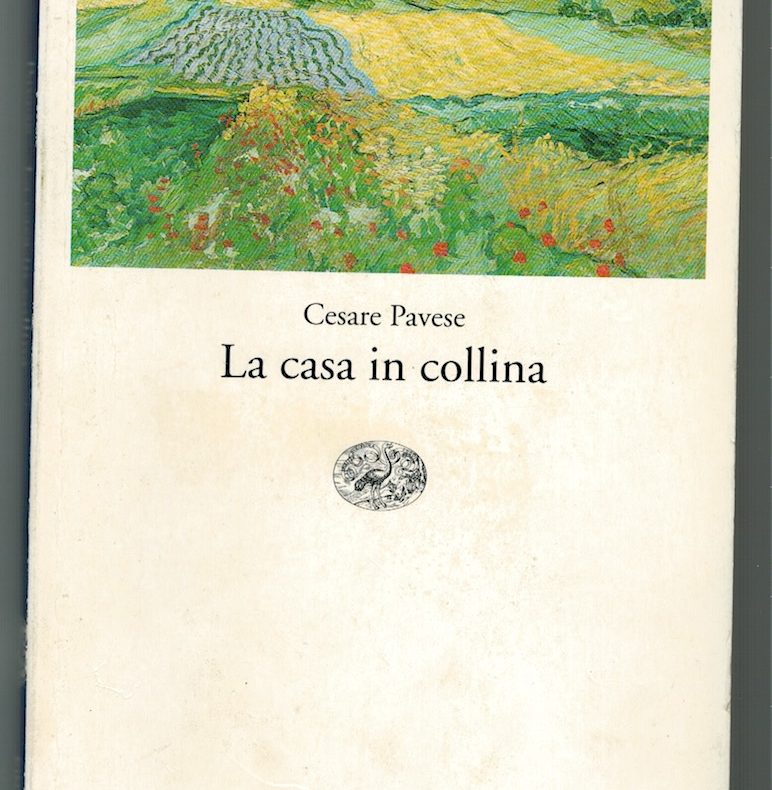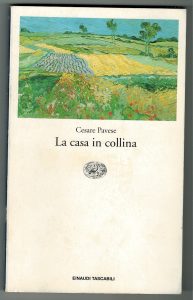
Cesare Pavese, La casa in collina, Einaudi Tascabili, 1990, credit Antiche Curiosità©
Lucio Pistis & Sandro Asebès©
Pavese, antifascismo, noia, gloria
.
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908 – Torino, 27 agosto 1950), è considerato da molti quasi alla stregua di un classico. Scrittore, traduttore e critico letterario.
Pavese deve la sua fortuna letteraria al fatto di aver fatto amicizia con molti intellettuali antifascisti di spicco della sua epoca: Leone Ginzburg, Norberto Bobbio, Massimo Mila e Giulio Einaudi.
Apprezzabile sicuramente il suo impegno antifascista, tuttavia ci domandiamo dopo aver letto La casa in collina, di che tipo di letteratura stiamo parlando.
Se la letteratura ha il compito di tediare e sfibrare il lettore con un pessimismo cupo che sa d’inerzia e di intellettualismo descrittivo, allora Pavese può a buon diritto rientrare nella categoria scrittori da ricordare. Ha una scrittura piuttosto ordinaria, senza impennate liriche, senza patetismi, lineare, corretta, senza follie sperimentali. Il problema è che le trame sono stanche, noiose, i personaggi scialbi, senza colore. Le descrizioni minuziose sui loro atti o sull’ambiente sono del tutto gratuite nel sistema del racconto, servono soltanto ad appesantire ferocemente la narrazione, rendendo la lettura difficoltosa, non perché l’autore usi un linguaggio difficile, tutt’altro, è molto semplice da capire, tutto molto chiaro, senza misteri, ma si perde in particolari privi di qualsiasi importanza strategica ai fini della trama, ci dà una miriade di informazioni di cui francamente potremmo fare a meno. In poche parole è uno degli autori più noiosi che abbiamo mai letto e lo diciamo senza acredine verso l’uomo e il suo pensiero. Però un autore va letto e dalla lettura si capisce di che pasta sia fatto. Per noi Pavese è stato enormemente sopravvalutato dalla critica. Il suo antifascismo, unito alle amicizie importanti, ha creato la sua fama. I suoi libri però non la giustificano.
La casa in collina è un romanzo che si fa fatica a leggere fino in fondo, è come un panino troppo carico in cui il condimento va a finire da tutte le parti, tranne che in bocca, lasciandoti deluso.
I personaggi hanno un’inerzia che non ci permette né di detestarli né di amarli, sono semplicemente indifferenti. I dettagli sulla guerra stancano perché ripetitivi e non funzionali ai personaggi. Si salta così dal romanzo alla cronaca documentaristica e anche la scelta di sposarsi diventa asettica e funzionale a un ruolo:
Fuori finiva un grosso incendio che aveva danneggiato un palazzo sul viale. Dei facchini portavano fuori i lampadari e le poltrone. Sotto il sole, alla rinfusa, avevano ammucchiato mobilio, tavolini con specchi, grosse casse. Quelle cose eleganti facevano pensare a una bella vetrina. Mi vennero in mente le cose di un tempo, le sere, i discorsi, i miei furori… Quando conobbi Anna Maria e la volli sposare. Sarei diventato assistente del padre. Avrei fatto dei viaggi. In casa sua si trovavano poltrone e cuscini, si parlava di teatro e di montagna.
Il racconto è completamente privo di pathos, di quella vibrante passione che rende viva la letteratura. Leggere La casa in collina fino in fondo per noi è stato un atto masochistico. Pavese pretende dal lettore sofferenza, non concede neppure un palpito, un attimo di gioia. Un autore pesante, una scrittura senza impennate che induce al sonno. Il suo impegno è noia, la sua scrittura atrocemente piatta, senza sorprese. E a volte indulge improvvisamente ai colloquialismi imprevedibili in uno chassis sempre nelle righe quanto a livelli compositivi; si pensi a questo passaggio:
Delle due preferivo la vecchia, la madre, che nella mole e negli acciacchi portava qualcosa di calmo, di terrestre, e si poteva immaginarla sotto le bombe come appunto apparirebbe una collina oscurata. Non parlava gran che, ma sapeva ascoltare. L’altra, la figlia, una zitella quarantenne, era accollata, ossuta, e si chiamava Elvira. Viveva agitata dal timore che la guerra arrivasse lassù. M’accorsi che pensava a me con ansia, e me lo disse: pativa quand’ero in città, e una volta che la madre la canzonò in mia presenza, Elvira rispose che, se le bombe distruggevano un altro po’ di Torino, avrei dovuto star con loro giorno e notte.
Nello spazio di poche righe troviamo:
un pronome personale sovrabbondante vista la chiara presenza del nome di riferimento a stretto giro (la vecchia, la madre);
una protasi del periodo ipotetico della possibilità espressa all’imperfetto indicativo anziché al trapassato prossimo del congiuntivo, a fronte di un’apodosi correttamente costruita col condizionale passato;
un verbo servile preceduto dall’ausiliario avere, benché sia seguito da un verbo (stare) che richiederebbe l’ausiliario essere.
Ma andiamo un attimo alla sostanza:
Dalla finestra sul frutteto avrei ancora veduto il mattino. Avrei dormito dentro un letto, questo sì. Gli sfollati dei prati e dei boschi sarebbero ridiscesi in città come me, solamente più sfiancati e intirizziti di me.
Al di là delle connotazioni meramente stilistiche soprammenzionate, a noi viene il sospetto, proprio in questo passaggio quasi esordiale del romanzo, di un approccio diremmo quasi radical-chic ante litteram da parte dell’intellettuale; ci perdoneranno i difensori a spada tratta del sano antifascismo di Pavese, ma questo discrimen ad effetto in confronto alla massa degli sfollati ci ricorda tanto la laudatio funebris preparata all’Onorevole ne “Il portaborse” di Nanni Moretti (che combinazione!), una sorta di captatio benevolentiae del borghese di turno, quasi a dire “Non prendetevela con me se ero nato benestante e vivevo la guerra meno sfigatamente di voi!”
Una certa presa di distanza, a nostro umilissimo avviso, quanto ad asfissia e ipossia nella luttuosità debordante, lo richiederebbe anche certa produzione poetica, dove l’autore si involve su se stesso e sullo spettrale pessimismo disperante, facendo ricorso alle anafore e alle allitterazioni nonché ai versus intercalares in una sorta di rimedio tecnico/tecnicistico teso a surrogare la zoppia nello slancio comunicativo; per esempio questa:
.
You, wind of March
Sei la vita e la morte.
Sei venuta di marzo
sulla terra nuda;
il tuo brivido dura.
Sangue di primavera
anemone o nube,
il tuo passo leggero
ha violato la terra.
Ricomincia il dolore.
Il tuo passo leggero
ha riaperto il dolore.
Era fredda la terra
sotto povero cielo,
era immobile e chiusa
in un torpido sogno,
come chi più non soffre.
Anche il gelo era dolce
dentro il cuore profondo.
Tra la vita e la morte
la speranza taceva.
Ora ha una voce e un sangue
ogni cosa che vive.
Ora la terra e il cielo
sono un brivido forte,
la speranza li torce,
li sconvolge il mattino,
li sommerge il tuo passo,
il tuo fiato d’aurora.
Sangue di primavera,
tutta la terra trema
di un antico tremore.
Hai riaperto il dolore.
Sei la vita e la morte.
Sopra la terra nuda
sei passata leggera
come rondine o nube,
e il torrente del cuore
si è ridestato e irrompe
e si specchia nel cielo
e rispecchia le cose,
e le cose, nel cielo e nel cuore
soffrono e si contorcono
nell’attesa di te.
È il mattino, è l’aurora,
sangue di primavera,
tu hai violato la terra.
La speranza si torce,
e ti attende ti chiama.
Sei la vita e la morte.
Il tuo passo è leggero.
.
Qualcuno ovviamente dirà che siamo due pazzi a bollare negativamente una delle glorie dell’Italia culturalmente antifascista, ma noi non abbiamo fatto altro che esternare delle impressioni obiettive che emergono dalla lettura; sperando che gli omologati al pensiero dominante abbiano la bontà di contestarle contro-argomentando.
.
https://antichecuriosita.co.uk/il-destrutturalismo-punti-salienti/
https://www.youtube.com/watch?v=NaaA0XJgStU